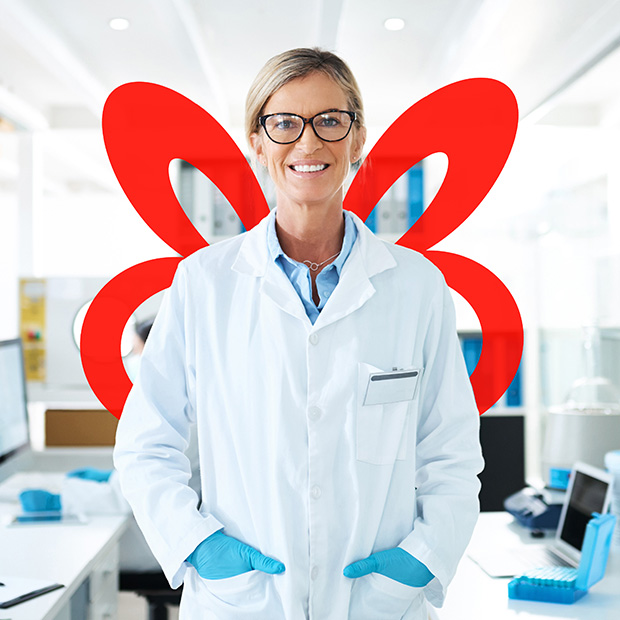Giovedì 20 marzo 2025, presso il Circolo Canottieri Aniene a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione organizzata dalla Fondazione Baroni. Un evento che ha illuminato l’impegno e i successi di diversi enti nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa, dello sport come mezzo di inclusione e della ricerca scientifica finalizzata al miglioramento della salute e della qualità di vita.
Qui la news con le foto e le dichiarazioni della serata del 20 marzo.
Alla serata ha partecipato la giovane booktoker Sara Ciafardoni, che ha parlato di inclusione e disabilità. Sara è anche diventata “Amica della Fondazione Baroni”.
Angela Sara Ciafardoni, giovane ragazza pugliese, è stata costretta, fin da bambina, a condurre una vita molto diversa dalla maggior parte dei suoi coetanei a causa di una rara malattia. Studentessa di giorno e divoratrice di libri di notte, blogger e bookstagrammer, nonostante le tante difficoltà, Sara non ha mai smesso di coltivare passioni e di perseguire il suo sogno di diventare scrittrice. Frequenta l’università e gestisce una pagina Instagram, @lasarabooks, dove condivide la sua passione per l’arte e la scrittura. Su TikTok, @lasaracfd, parla di libri e ironizza sulla disabilità e i tabù che la riguardano per sensibilizzare su questa tematica. Oggi Sara è una scrittrice amata e affermata. Ha pubblicato: La ragazza che scrive (Mondadori Electa Young 2023) e Sono ancora qui (Mondadori Electa Young 2024).
Le parole di Sara Ciafardoni
“Cosa significa davvero inclusione? Forse avete già una risposta chiara.
Beh, io no. Non perché non la conosca, ma perché mi sembra impossibile rinchiuderla in una definizione.
Per tanti è un concetto da sbandierare, per me è sempre stata la normalità. Non ho dovuto impararla né etichettarla, l’ho vissuta prima ancora di sapere come chiamarla. E di una cosa sono certa: l’inclusione è fatta di gesti, piccoli e silenziosi, capaci di cambiare il mondo.
Ma davvero serve darle un’unica definizione? Sarebbe come cercare di ingabbiare un’emozione. Nessuno riesce a provare la stessa felicità due volte nello stesso modo, e lo stesso vale per l’inclusione: è concreta, reale, ma troppo grande per essere ridotta a una formula.
Per molte persone sono nata “diversa”, ma mi chiedo: diversa? Ma diversa da chi? Chi può permettersi di classificare chi o come entra nella categoria dei “non diversi”, o meglio “normali”? Io mi sento semplicemente me stessa, tenace e intraprendente, e non ho mai amato le classificazioni.
Eppure, per tanto tempo, ho creduto a quello che mi dicevano. Ed è proprio qui che entra in gioco un fenomeno che accade a tutte le latitudini e che, in fondo, è successo anche a voi: si chiama Effetto Pigmalione, o anche Effetto Rosenthal.
Ma chi era questo Rosenthal?
Era uno psicologo che, nel 1963, ad Harvard, studiava il pregiudizio umano attraverso esperimenti con i topi da laboratorio. I suoi studi gli fecero ottenere risultati interessanti, fino a quando ricevette una lettera da una preside di una scuola che lo invitava a condurre gli stessi esperimenti sugli studenti. Lui accettò e, insieme alla preside mise in atto uno scherzo che ha fatto la storia.
Selezionarono casualmente alcuni alunni e riferirono agli insegnanti che quei bambini erano “futuri geni”, destinati a eccellere. In realtà, non avevano alcun talento speciale, erano stati scelti a caso.
Dopo un anno, Rosenthal tornò in quella scuola e notò un risultato sorprendente: i bambini indicati come “geniali” avevano migliorato le loro prestazioni scolastiche, superando i compagni. Il motivo? Gli insegnanti, credendo nella loro genialità, avevano trasmesso loro fiducia, incoraggiamento e attenzioni particolari.
Il risultato dimostrò qualcosa di potentissimo: le aspettative che gli altri hanno su di noi influenzano direttamente chi siamo e chi possiamo diventare. Se ti vedono come capace, finisci per esserlo. Se ti vedono come un peso, è più probabile che tu ti senta tale.
E allora mi chiedo: cosa accade se, invece di aspettative di crescita, una persona riceve solo limiti e barriere?
Io lo so bene, perché l’ho vissuto sulla mia pelle.
Ricordo un episodio in particolare, quando ero ancora bambina. Ero seduta accanto a mia nonna davanti alla televisione. Trasmettevano un servizio su un politico in sedia a rotelle, una figura autorevole, che parlava con sicurezza.
Mia nonna lo guardò e disse: “Ora anche i disabili ci governano.” Non c’era in lei la meraviglia di chi assiste a un cambiamento storico. La sua voce era dura, quasi rassegnata, come se vedesse in quell’immagine qualcosa di innaturale, qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere. Io ero ancora una bambina e non capivo del tutto, ma sapevo che quelle parole non mi piacevano. Ecco, ero semplicemente una bambina che voleva vivere la sua infanzia: non potevo correre, ma potevo giocare e
fare grandi sogni; non potevo saltare, ma questo non può essere considerato un limite, la mia creatività potevo comunicarla perché sono dotata di un cuore, di un’anima e di una mente pensante.
Perché sarebbe dovuto essere un problema che un disabile governasse? E, soprattutto, se il mondo in cui crescevo aveva spazio per un uomo come quello in televisione, perché io continuavo a sentirmi fuori posto?
Solo dopo ho capito che mia nonna non aveva detto quelle parole per ferirmi. Le aveva dette per paura. Paura del mio futuro, paura di un mondo che non conosceva. Ma non lo avrebbe mai ammesso.
Non era il tipo da parlare di emozioni. E forse nemmeno sapeva spiegarsi il motivo per cui sentiva quel disagio.
Con il tempo ho capito che mia nonna era un po’ come Gianciotto. Quando ho letto la storia di Paolo e Francesca, ho scoperto qualcosa che mi ha cambiata. Si parla sempre di loro due, i due amanti che si baciano leggendo un libro e che Dante condanna a un eterno vortice nel girone dei lussuriosi. Ma quasi nessuno parla del terzo protagonista della storia: Gianciotto Malatesta, il marito tradito, l’uomo che, accecato dalla rabbia, uccide entrambi.
Per molto tempo lo avevo immaginato come tutti lo descrivono: il cattivo, il carnefice, un uomo crudele e violento. E in parte lo era. Nessun dolore, nessuna frustrazione può mai -ripeto, mai – giustificare un atto di violenza. Il tradimento fa soffrire, ma non può mai essere un motivo per togliere la vita a qualcuno. Gianciotto ha scelto la vendetta, ha scelto di farsi divorare dalla rabbia. E per questo resta colpevole.
Eppure, leggendo la sua storia, qualcosa in me si è spezzato. Ho scoperto che Gianciotto non era solo il marito tradito. Era il brutto anatroccolo che non si era mai trasformato in cigno. Era il figlio messo in ombra dal fratello bello e affascinante, l’uomo che, pur amando sua moglie, non era
mai stato visto, mai stato scelto.
Non conosceva l’amore. Credeva di amarlo, certo, ma non lo aveva mai capito davvero. Perché chi ama non ferisce, chi ama non fa male. E lì ho capito: Gianciotto non era il cattivo della storia. Era solo qualcuno che non aveva mai ricevuto abbastanza amore per sapere come restituirlo.
E allora ho pensato a mia nonna. Perché quella frase che mi aveva ferito, quel giudizio così duro, non veniva dalla cattiveria. Veniva dall’ignoranza.
Ma cos’è davvero l’ignoranza?
Non è semplicemente non sapere qualcosa. Non è solo il non conoscere una realtà diversa dalla propria. L’ignoranza è la paura di ciò che non si conosce. È la corazza di chi, come Gianciotto, come mia nonna, ha vissuto tutta la vita con una sola visione delle cose e ora si sente perso di fronte a un mondo che cambia. L’ignoranza è una prigione, ma la chiave per aprire la porta esiste sempre. E quella chiave risiede nell’amore. Non l’amore idealizzato, romantico, quello che ci raccontano nei film. Parlo dell’amore come atto rivoluzionario. E il mio atto rivoluzionario più grande, più di qualsiasi parola detta o battaglia combattuta, è stato abbracciare mia nonna. Abbracciarla anche se quella frase mi aveva ferita. Abbracciarla anche se sapevo che avrebbe continuato a pensare come aveva sempre
pensato. Perché se l’amore è dare tutto senza chiedere nulla in cambio, allora io avevo appena fatto il gesto più potente della mia vita.
E se in un libro ho letto la frase: “Noi siamo quello che diamo, e non ciò che riceviamo”, allora la mia cura per l’ignoranza nasce da lì. Nasce dal mio abbraccio a mia nonna. E arriva fino a oggi, fino alla Fondazione Baroni, che supporta la ricerca, lo sport, la solidarietà.
Se oggi sono qui, in questa stanza, a raccontarvi la mia storia, è perché qualcuno ha creduto nella ricerca. Io stessa qualche anno fa mi sono sottoposta a un intervento sperimentale. Ma la ricerca da sola non basta.
Se sono qui, è anche perché i miei genitori mi hanno dato la chiave più importante: la cultura. Mi hanno insegnato a farmi domande, a non accettare i limiti imposti dagli altri, a costruire il mio percorso senza
paura. Se sono qui, è perché ho avuto medici che non si sono limitati a curarmi, ma che mi hanno insegnato a non sentirmi solo un caso clinico, ma una persona con un futuro.
Per me, tutto questo è stato naturale. Ho avuto accanto persone che mi hanno dato accesso alla conoscenza, alla medicina, alla possibilità di scegliere il mio futuro. Ma non per tutti è così.
Ed è qui che la Fondazione Baroni diventa fondamentale. Perché ci sono persone che non hanno avuto i miei stessi privilegi. Giovan Battista Baroni, con il suo testamento, aveva disposto che il proprio patrimonio fosse destinato a opere di bene. Ma a me verrebbe da dire: a opere di bene, e specialmente d’amore. Perché è questa la cura a tutti i mali del mondo”.